
Situato nel centro di Trieste a poca distanza dalla riva del mare, il Museo Revoltella è una galleria d’arte moderna fondata nel 1872 per volontà del barone Pasquale Revoltella (1795-1869), una delle figure più rappresentative della società triestina dell’Ottocento, che lasciò alla città, oltre a molti altri beni, la sua casa e tutte le opere d’arte, gli arredi e i libri che conteneva.
Il palazzo originario, un’elegante costruzione neorinascimentale di tre piani, edificata tra il 1854 e il 1858 su progetto del berlinese Friedrich Hitzig, si affaccia su piazza Venezia, un tempo chiamata piazza Giuseppina in memoria dell’imperatore austriaco (Giuseppe II, figlio di Maria Teresa) sotto il quale, alla fine del ‘700, era avvenuta l’espansione di quest’area della città.
Grazie alla disponibilità finanziaria lasciata dal fondatore per il mantenimento e lo sviluppo dell’istituzione, ma anche per svolgere una funzione educativa nei confronti dei giovani artisti e degli artigiani, in pochi decenni il Museo Revoltella si arricchì di un cospicuo numero di opere d’arte di notevole valore (spesso acquistate alle prime Esposizioni internazionali, tra cui la Biennale di Venezia) che resero necessario l’ampliamento della sede.
Una rappresentativa selezione delle numerosissime opere acquisite dal 1872 in poi occupa, invece, gli spazi completamente rinnovati di palazzo Brunner, articolata in quattro piani secondo la seguente sistemazione: al terzo piano gli autori italiani del secondo Ottocento (Fattori, Induno, Palizzi, Morelli), al quarto piano gli acquisti effettuati – tra la fine dell’Ottocento e la prima guerra mondiale – alle Esposizioni internazionali (De Nittis, Nono, Ciardi, Trentacoste, Canonica, Bistolfi, Carena, von Stuck, Zuloaga), al quinto piano gli artisti del primo Novecento a Trieste e in Italia (Marussig, Bolaffio, Timmel, Dudovich, Casorati, Sironi, Carrà, de Chirico, Martini) e,in una galleria più piccola, gli artisti del Friuli-Venezia Giulia degli ultimi cinquant’anni (Zigaina, Afro, Dino e Mirko Basaldella, Spacal, Perizi) mentre i protagonisti del panorama nazionale del secondo Novecento trovano posto nella grande sala del sesto piano che si apre alla vista della città e del mare. Da qui si può uscire sulla grande terrazza, disegnata pure da Carlo Scarpa, e vedere uno splendido panorama. Nelle sere d’estate (dal 15 luglio ai primi di settembre, da giovedì a domenica) in questi spazi è in funzione un caffè aperto fino a mezzanotte.
I direttori

1872-1883
I primi due direttori furono il pittore Augusto Tominz (dal 1872 al 1883) e il figlio di questi Alfredo (dal 1883 al 1926).
Nel 1907 fu acquistato dal Comune il vicino palazzo Brunner che, però, fu utilizzato solo a partire dagli anni Trenta con la direzione di Edgardo Sambo (1929-1956).

1929-1956
Appena nel 1963, con l’affidamento del progetto di ristrutturazione a Carlo Scarpa, fu messo totalmente a disposizione del museo assieme ad un edificio attiguo, il palazzo Basevi.
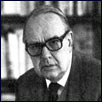
1960-1989
Dal 1960 era direttore Giulio Montenero, che ricoprì questa carica fino al 1989.
L’ampliamento del museo, che avrebbe dovuto concludersi nel 1968 per festeggiare i 50 anni dell’unione di Trieste all’Italia, incontrò invece molte difficoltà e interruzioni e terminò solo nel 1991, dopo che a Scarpa erano subentrati, in un primo momento, l’architetto Franco Vattolo e, alla fine degli anni Ottanta, l’architetto Giampaolo Bartoli.
Da allora il museo occupa tre palazzi che formano un intero isolato, delimitato da piazza Venezia e dalle vie Diaz, Cadorna e San Giorgio.

1992-2015
Dal 1992 al 2015 il Museo Revoltella, con la direzione di Maria Masau Dan, è stato definitivamente riaperto con un percorso che si sviluppa in tutto lo spazio ora disponibile (circa 4000 mq di esposizione con 350 opere di pittura e scultura distribuite in sei piani) e ha recuperato anche la dimora del fondatore con i suoi arredi e le sue collezioni rimosse nel tempo per fare posto ai nuovi acquisti.
Dal 2012 Masau Dan ha ricevuto anche l’incarico della direzione dei Civici Musei di Storia ed Arte.

Nel periodo compreso tra dicembre 2015 e aprile 2017, la direzione del Museo Revoltella e dei Civici Musei di Storia ed Arte è stata affidata ad interim a Bianca Cuderi, già direttrice delle Biblioteche comunali (dicembre 2015 – giugno/dicembre 2016) e in seguito a Nicola Bressi (giugno 2016 – aprile 2017), già direttore dei Musei scientifici.
Da maggio 2017 a ottobre 2021 l’incarico del Servizio Musei e Biblioteche è stato affidato a Laura Carlini Fanfogna.
La storia del Museo anno per anno
1992
Alla fine del 1991 terminano i lavori di ristrutturazione della Galleria d’arte moderna, ospitata a Palazzo Brunner, vasto edificio ottocentesco adiacente a Palazzo Revoltella. Erano iniziati alla metà degli anni Sessanta, dopo l’affidamento del progetto a Carlo Scarpa, ed erano continuati, fra molte interruzioni, per oltre vent’anni. La fase finale è diretta dall’architetto Giampaolo Bartoli. Non appena gli spazi sono disponibili, nella primavera del 1992 vengono selezionate circa 350 opere del patrimonio di pittura e scultura posseduto dal museo, e il 13 giugno il Revoltella viene finalmente riaperto al pubblico con una mostra che si intitola “Da Canova a Burri. Il museo in mostra”.
1993
La città riscopre a poco a poco il Museo Revoltella, che molti avevano dimenticato. La rinascita non è comunque facile. Occorre ricostruire una rete di rapporti attorno al museo e, soprattutto, occorre riorganizzare l’attività, che purtroppo non può contare su una struttura adeguata e su risorse finanziarie proporzionate all’importanza del museo. Tuttavia si riesce ad avviare un processo di normalizzazione, sia pure lento, e ricominciano a funzionare quasi tutti i servizi, la biblioteca, la didattica, la ricerca. In ottobre si apre una mostra antologica di Cesare Sofianopulo (1889-1968) uno dei personaggi più originali del Novecento triestino, figura molto rappresentativa di quella generazione che si era formata ai tempi dell’Austria e aveva vissuto da protagonista il passaggio della città all’Italia.
1994
Si decide di organizzare una mostra sul paesaggio dell’Ottocento e del Novecento, suggerita dalla scoperta, avvenuta durante il riordino delle collezioni precedente alla riapertura del ’92, di un consistente nucleo di dipinti di questo genere, tra cui parecchi provenienti dalla collezione del barone Revoltella. La mostra si intitola “Punti di vista. Il paesaggio dalle collezioni del Revoltella alla cultura contemporanea” e comprende anche alcune sezioni dedicate alla fotografia, al disegno, all’editoria, alla tutela dell’ambiente, all’arte contemporanea. E’ la prima mostra interdisciplinare, che vede impegnato un folto gruppo di collaboratori.
Dalla primavera il museo supera i gravi problemi di sorveglianza grazie alla collaborazione di due associazioni, gli “Amici dei Musei” e “Cittaviva”, che mettono a disposizione oltre cinquanta volontari, e viene finalmente aperto alla visita con un orario giornaliero di apertura molto ampio.
In autunno si realizza una mostra di disegni dell’architetto Enrico Nordio (1851-1923) provenienti dalla collezione dell’Istituto Statale d’Arte di Trieste.
1995
Partono con quest’anno le ricerche sul secondo Novecento, incentrate soprattutto sullo sviluppo del museo sia per quanto riguarda il progetto di ampliamento della sede (da Scarpa in avanti) sia in termini di crescita del patrimonio. Da qui nasce l’idea della mostra “Anni fantastici. Arte a Trieste dal 1948 al 1972” che descrive il contesto culturale con cui si confronta in quegli anni l’attività del Revoltella. Il ’95 è un anno intensissimo. Si opera su tematiche molto diverse ma tutte stimolanti: la mostra “Dualità. Aspetti della cultura slovena a Trieste” amplia la ricerca di “Anni fantastici” alle vicende culturali di ambito sloveno, mentre “Dall’aquila al leone” introduce, attraverso la storia delle Assicurazioni Generali, la grande mostra (“Sogno e consapevolezza del cosmopolitismo triestino”) dedicata alla figura di Pasquale Revoltella nel bicentenario della nascita. L’estate è dedicata a un protagonista della pop art americana, James Rosenquist, che progetta personalmente la mostra della sua produzione recente per il Museo Revoltella. L’anno del centenario della Biennale, istituzione a cui il museo è strettamente legato perché lì furono fatti i più importanti acquisti della sua storia, si chiude con una grande mostra intitolata “Arte d’Europa tra due secoli 1894-1914. Trieste, Venezia e le Biennali” e organizzata assieme alla Galleria di Ca’Pesaro.
1996
Continua la serie delle “star” internazionali con la mostra “Jim Dine’s Venus”, organizzata con la Galleria Ropac di Salisburgo, che ha un’appendice spettacolare nel Teatro romano, dove sono esposte tre gigantesche “Veneri” del maestro americano. L’estate 1996 vede, però, anche l’avvio di un ciclo di mostre dedicate ai protagonisti del Novecento triestino che parte con la retrospettiva di Nino Perizi (1917-1994) e prosegue qualche mese più tardi con Carlo Sbisà (1898-1964). Quest’ultima mostra si inserisce in un progetto di ricerca sugli anni venti e trenta da cui deriveranno molte rassegne successive, a cominciare da quella dedicata a uno dei più brillanti critici triestini di quel tempo e intitolata “Viaggio nel è900. Le collezioni di Manlio Malabotta”.
1997
“Arte e Stato. Le esposizioni sindacali nelle Tre Venezie (1927-1944)” è il frutto del lavoro compiuto sul primo Novecento da un ampio gruppo di lavoro coordinato da Enrico Crispolti e si realizza con la collaborazione di tutte le più importanti istituzioni museali del triveneto. Le altre mostre dell’anno sono dedicate all’arte contemporanea: compaiono per la prima volta le nuove generazioni in “Zone d’arte. Alterazioni del quotidiano”, ma poco dopo un doveroso momento celebrativo è riservato a un anziano maestro, Luigi Spacal in occasione dei suoi novant’anni. Seguono le mostre di due forti personalità della generazione di mezzo, l’udinese Carlo Ciussi e il triestino Bruno Chersicla. L’anno si chiude con una singolare esposizione, “Il fascino dello stile. Gli abiti storici delle sorelle Fontana”, accolta con molta curiosità sia perché la moda entra per la prima volta in museo sia perché gli abiti sono esposti in mezzo alle opere d’arte.
1998
Anche il ’98 si ricorda come un anno fitto di mostre. La rassegna più impegnativa, “Nella Trieste di Svevo. L’opera grafica e pittorica di Umberto Veruda (1868-1904)” è dedicata al maggiore pittore del secondo Ottocento. Per quanto riguarda l’arte contemporanea, si continua a valorizzare i giovani con la rassegna “Punto video. Arte & tecnologia” e con le tre personali dedicate a Carlo Bach, Davide Skerlj e Lorena Matic sotto il titolo “Strada facendo”, ma in autunno compare anche una celebrità internazionale con David Byrne e le sue fotografie. Il Museo Revoltella collabora, inoltre, alla manifestazione “Shalom Trieste” con una mostra dei pittori del Novecento triestino di origine ebraica. E a un altro grande legato a Trieste è dedicata la singolare rassegna “Joyce sight. Artisti irlandesi per James Joyce” promossa dalla Joyce School. Due architetti amanti della pittura e della scultura, Antonio Guacci ed Ennio Cervi, sono i protagonisti di altre due mostre del è98, che si ricorda anche per una preziosa esposizione di abiti di Renato Balestra, stilista triestino che naturalmente suscita una larga curiosità nel pubblico.
In dicembre si aprono due mostre importanti: la prima presenta l’opera di Augusto Cernigoj (1898-1985), figura centrale e originalissima del Novecento, passato per la Bauhaus e le avanguardie, la seconda ripercorre l’attività di un grande maestro dell’architettura contemporanea, Boris Podrecca, allievo in gioventù di Cernigoj e autore del raffinato allestimento della sua mostra.
1999
Sulla scia del successo ottenuto dalle mostre di Rosenquist (1995) e Dine (1996) viene organizzata assieme alla Galleria Bischofberger di Zurigo una grande mostra di Jean Michel Basquiat, che attraverso una selezione di oltre cento opere presenta il meglio della produzione di questo mito dell’arte americana e ottiene una straordinaria attenzione dal pubblico e dalla critica. Contemporaneamente in altri spazi del museo viene allestita una singolare rassegna intitolata “Musica senza suono. Segni e disegni di musicisti italiani” in cui si possono vedere dipinti di Franco Battiato, Jovanotti, Augusto Daolio, Laura Pausini, Elisa, Gino Paoli, ecc.
Da ricordare anche l’esposizione “Pittura triestina tra è800 e è900 nelle collezioni del Museo Revoltella” ospitata tra maggio e giugno nel Museo di Belle Arti di Budapest per iniziativa dell’Istituto Italiano di Cultura e, in autunno, una rassegna sul tema del nudo allestita attingendo al patrimonio museale.
2000
Ancora una figura rappresentativa degli anni venti e trenta, Giannino Marchig, è oggetto dell’attività di ricerca svolta dal Museo Revoltella sul Novecento. A questa si affianca una mostra dedicata a Gino de Finetti, pittore e cartellonista goriziano di cui si ospitano le opere in collaborazione con i Musei provinciali di Gorizia.
Gli studi sulle raccolte museali si concentrano, invece, sull’importante collezione di autoritratti, oltre cento pezzi, che vengono studiati e schedati, e messi in mostra durante l’ estate. Seguono alcune antologiche dedicate a personalità molto significative dell’arte contemporanea: inizia la serie Zigaina, che allestisce una bellissima mostra al quinto piano del museo in cui sono illustrati i momenti più alti di quasi sessant’anni di attività del maestro friulano. Alla fine dell’anno si inaugura una spettacolare rassegna di Edo Murtic, il maggiore artista della Croazia, giunto alla soglia degli ottant’anni, ma ancora attivissimo e vivace. Una curiosa esposizione di disegni di Bruno Schulz, il grande scrittore polacco, completa il programma del 2000.
2001
L’evento dell’anno è certamente il restauro delle facciate di Palazzo Revoltella, che torna così al suo originario splendore, dopo essere stato nascosto per decenni sotto la patina grigia dello smog cittadino. Il lavoro si realizza sotto la direzione dell’architetto Giampaolo Batoli.
Grandi nomi dell’arte internazionale sono presenti nella mostra “Odissee dell’arte”, aperta in primavera, ma non si trascura di offrire ospitalità anche ai più significativi rappresentanti dell’ambiente triestino seguendo il filone delle antologiche già ricco di nomi. Quest’anno tocca a Claudio Palcic con una selezione di opere che documenta ampiamente la sua ormai quarantennale attività. L’estate è dedicata ad Arturo Martini, di cui viene presentata la straordinaria collezione di sculture posseduta dalla Banca Popolare di Vicenza.
2002
Anno memorabile sia per la varietà e la qualità degli eventi espositivi sia per l’aumento eccezionale di visitatori che passano da ventimila, numero medio degli anni precedenti, a cinquantacinquemila grazie soprattutto alla mostra “Klimt, Schiele, Kokoschka. L’età d’oro di Vienna con i suoi maestri” aperta da febbraio ad aprile. Anche altre proposte concorrono a questo successo: piace molto la serie di ritratti tra Neoclassicismo e Biedermeier di Giuseppe Tominz (1790-1866), raccolti in una mostra che poi verrà trasferita alla Narodna Galerija di Lubiana e ai Musei provinciali di Gorizia, così come incuriosisce moltissime persone la rassegna “Arte e psicanalisi. Volti”, che indaga sui rapporti tra la pittura triestina, la letteratura e l’attività di Edoardo Weiss allievo triestino di Freud. Non molto distante, per le sue implicazioni col surrealismo, è la mostra “Pittura fantastica in Italia. Da de Chirico a Leonor Fini”, che viene presentata più o meno nello stesso periodo, ma, naturalmente allarga lo sguardo oltre la realtà locale. L’anno finisce con l’apertura della grande mostra “Marcello Dudovich. Oltre il manifesto” dedicata al più grande maestro del cartellonismo italiano, triestino di nascita e milanese di adozione, di cui vengono esposti non solo più di cento dei suoi più interessanti manifesti, ma anche molti dipinti e disegni per fare conoscere un aspetto meno noto della sua multiforme attività.
2003
Dopo Klimt il collegamento fra Trieste e i più celebri esponenti dell’arte europea continua con Renoir, di cui si allestisce una mostra nella nuova sede espositiva dei Musei del Canal Grande (Palazzo Gopcevic). Al Museo Revoltella, invece, conclusa con un bilancio molto soddisfacente la mostra di Dudovich, si apre “Crali e il volo dei futuristi” una rassegna di aeropittura organizzata per ricordare il centenario del primo volo ma anche un grande pittore di origine giuliana scomparso nel 2000. Nel contempo, sempre nella sede dei Musei del Canal Grande, nello spazio della “Sala Leonardo”, si avvia una nuova serie di mostre personali con il marchio “Revoltella contemporaneo”: durante l’estate e l’autunno si succedono tre fra i più interessanti artisti triestini, Manuela Sedmach, Antonio Sofianopulo e Mario Sillani. Il Museo promuove inoltre assieme al Gruppo 78 una rassegna intitolata “Imagerie” e incentrata sul rapporto tra arte e moda.
In autunno viene riallestita a Budapest, per iniziativa dell’Istituto culturale centro europeo, la mostra “Arte e psicanalisi. Volti” che si apre il 5 novembre con un convegno internazionale.
Tra novembre e dicembre si inaugurano al Museo Revoltella due mostre dedicate a maestri triestini: la prima illustra la fase giovanile di uno straordinario artista giunto ai novantacinque anni, (“Ugo Carà. Arte, architettura, design”), la seconda celebra, a dieci anni dalla scomparsa, Edoardo Devetta, uno dei migliori interpreti triestini della linea informale.
2004
In aprile, nell’ambito del programma “Revoltella contemporaneo” si inaugura a Palazzo Gopcevich la mostra “Daniel Spoerri. La messa in scena degli oggetti”, mentre nella sede del museo, in maggio, si presenta, nel salone del sesto piano, una mostra dedicata a “Carlo Scarpa e il Museo Revoltella” basata sulla raccolta degli schizzi e dei progetti presenti nell’archivio dell’architetto e conservati ora, dalla DARC (Direzione per l’Architettura e l’Arte Contemporanea del Ministero per i Beni Culturali). Intanto l’assessorato alla cultura avvia le celebrazioni del cinquantesimo anniversario del ritorno di Trieste all’Italia e anche il Museo Revoltella partecipa alle mostre programmate per rievocare gli anni cinquanta, organizzando, durante l’estate, due piccole esposizioni di abiti femminili dell’epoca (di cui una realizzata grazie alla collaborazione di numerose signore della città che hanno aperto i loro guardaroba èstorici’ – “Moda anni cinquanta in passerella” a Palazzo Costanzi – e la seconda a una collezione di abiti d’epoca appartenuti all’imperatrice Soraya), ma contribuendo anche all’articolata rassegna storica presentata in novembre nella Piscina Bianchi con la sezione dedicata all’architettura e alla decorazione navale.
Nella sede del museo, invece, l’evento espositivo più importante dell’anno è la mostra dedicata a Guido Marussig.
In autunno esce il catalogo generale del museo pubblicato con il sostegno della Banca Friuladria.
2005
In primavera la mostra di Paolo Patelli continua il filone “Revoltella contemporaneo” con una bella rassegna ospitata nel soppalco dell’auditorium, mentre altri spazi del museo accolgono le opere di un pittore molto amato a Trieste, Livio Rosignano.
Esce nel frattempo il volume “Arte e psicanalisi nella Trieste del Novecento” che viene presentato in giugno.
All’inizio dell’estate si allestisce al quinto piano la mostra “Histria. Opere d’arte restaurate da Paolo Veneziano a Tiepolo” a cui il Museo Revoltella offre ospitalità in attesa che venga trovata una sede definitiva per questo interessantissimo nucleo di opere provenienti dalle chiese istriane e ricoverate a Roma durante la seconda guerra mondiale.
Da luglio a settembre resta aperta la mostra della “Donazione Kurlander”, una quarantina di opere di artisti triestini di primo piano frutto di una delle più importanti donazioni ricevute dal museo. La mostra sarà ospitata per un mese dalla Galleria d’arte moderna di Udine.
In autunno la Sala di Palazzo Costanti sarà utilizzata dal Museo per la mostra retrospettiva di Romolo Bertini.
In dicembre si inaugurano due mostre strettamente collegate: “La mano, l’occhio, il progetto: l’esperienza del fare” organizzata per ricordare i cinquant’anni di fondazione dell’Istituto Statale d’arte “Nordio” e una grande antologica di Dino Predonzani “Sogni di mare e di terra”, valente pittore e decoratore di navi, nonché insegnante per lunghi anni nella stessa scuola.
2006
E’ l’anno di Carlo Scarpa, l’architetto che ha progettato negli anni Sessanta la ristrutturazione dell’ala moderna del museo. In giugno si rinnova l’allestimento della galleria e si pubblica il volume “Carlo Scarpa e il Museo Revoltella”.
Alla fine dello stesso mese si apre la mostra “Lessico familiare. La donazione Gruber Benco” dedicata a una collezione di opere d’arte ricevuta recentemente in dono da una importante famiglia triestina.
Nell’ambito del progetto “Revoltella contemporaneo” l’estate 2006 è dedicata all’opera di Giorgio Valvassori di cui al quinto piano del museo sono esposte opere particolarmente rappresentative della sua attività.
Alla fine di settembre, per la seconda fase dello stesso ciclo di eventi, viene allestita la mostra di Odinea Pamici “Folie bourgeoise” nella piccola galleria del quinto piano e in una parte di Palazzo Revoltella.
In novembre viene inaugurata la mostra “Piero Marussig”, dove vengono esposte una sessantina di dipinti di questo straordinario interprete della pittura del suo tempo.
2007
2008
Il 12 aprile il Museo Revoltella ospita il convegno intitolato “Psicoanalisi, arte e storia” dedicato alla memoria di Anna Maria Accerboni, nota studiosa di storia della psicoanalisi, scomparsa prematuramente nel 2006. Vi partecipano molti docenti e psicoanalisti che hanno condiviso il suo percorso scientifico e professionale.
Tra marzo e aprile si organizza la mostra della collezione d’arte della sede RAI del Friuli – Venezia Giulia, che vanta i nomi più importanti dell’arte regionale. La mostra presenta anche filmati prodotti dalla RAI con interviste agli artisti, alcuni dei quali sono anche presenti all’inaugurazione. Dal Revoltella la mostra passa poi ad essere ospitata dalla Galleria d’arte moderna di Udine.
Subito dopo il Museo Revoltella accoglie un’altra importante collezione cittadina d’arte contemporanea attraverso la mostra “1953: l’Italia era già qui. Pittura italiana contemporanea a Trieste”, in cui viene rievocata una lontana rassegna organizzata dall’Università. In questa esposizione trovano spazio le opere di settantacinque artisti, tra i più rappresentativi delle tendenze pittoriche degli anni Cinquanta.
In ottobre viene allestita la mostra “Luci dell’Adriatico. Paesaggi di mare tra Venezia e Trieste nell’Ottocento”, in cui si ripercorre l’evoluzione della pittura di paesaggio nell’area veneta e giuliana.
In novembre si inaugura la mostra “Federico Righi nel centenario della nascita. Colori di una vita”, con la collaborazione di Giuliano Righi, figlio dell’artista. Vengono esposte circa una settantina di opere dagli anni Trenta agli anni Ottanta, oltre a lavori legati alle attività di scenografo e decoratore navale di Righi.
2009
Il 9 maggio un incontro a più voci intitolato “Zoran Music pittore europeo”, realizzato in collaborazione con l’associazione “Iniziativa europea”, ricorda l’artista nel centenario della sua nascita.
Nel 2009 il Museo Revoltella riprende a ricoprire il ruolo di rappresentanza istituzionale e di sede per incontri governativi, allestendo nel salone da ballo del Palazzo baronale una cena di gala in occasione del G8 Foreign Minister’s Meeting.
In luglio s’inaugura la più grande mostra antologica mai dedicata a Leonor Fini, dal titolo “Leonor Fini. L’italienne de Paris”, che ripercorre la lunga carriera di questa straordinaria e singolare artista. Il progetto si realizza grazie alla collaborazione della Galerie Minsky di Parigi e di due prestigiosi galleristi americani, quali Rowland Weinstein e Neil Zukerman. Sono esposti 250 pezzi, tra dipinti, disegni, libri e fotografie in un articolato percorso che si snoda attraverso tutto il Museo.
In dicembre si apre la mostra “Giorgio Carmelich. Futuristicherie. Viaggi d’arte fra Trieste, Roma e Praga”, che celebra il centenario del Futurismo. Vengono esposti più di 130 pezzi tra dipinti, collages, disegni, incisioni, periodici e monografie per descrivere al meglio la personalità di Carmelich, pittore, scenografo, critico, editore e grafico.
2010
In collaborazione con la stazione Rogers si espone al Museo Revoltella una selezione di opere della collezione di Enrico Matauro, cultore del futurismo e proprietario di opere di Malevich, Goncharova, Exter, Baranoff Rossiné, Lentulov, ecc. Un fitto programma di eventi (mostre, concerti, conferenze e laboratori) contribuisce a celebrare il centenraio del Futurismo.
Durante l’estate, tra luglio e agosto, sulla terrazza panoramica del Museo Revoltella si organizzano alcune serate dedicate alla degustazione dei migliori vini del Carso, curata dal sommelier Claudio Donat e arricchite da una serie di conferenze tenute dall’esperto di storia della viticoltura Stefano Cosma. La manifestazione, che porta il titolo “Calici d’arte”, si ripeterà con successo anche nel 2011 e nel 2012.
Dall’estate del 2010 s’inaugura il racconto del museo in forma teatrale, grazie allo spettacolo itinerante “Un caffè col barone” (regia di Davide Del Degan), che conduce 30-40 spettatori attraverso i tre piani di Palazzo Revoltella per la durata di 40 minuti. Il barone è interpretato dall’attore Lorenzo Acquaviva, mentre Ivan Zerbinati recita nei panni di un amico del padrone di casa. Visto l’incredibile successo, lo spettacolo verrà riproposto negli anni successivi superando le mille repliche.
E’ di ques’anno anche la rassegna “Roberta di Camerino. La rivoluzione del colore” , che vede dialogare con le opere d’arte le borse storiche della stilista veneziana, ma anche i suoi famosi abiti e gli ombrelli degli anni Sessanta.
2011
La mostra “Autoritratti triestini. La donazione Hausbrandt”, accompagnata da un catalogo, rende il giusto merito alla famiglia di Roberto Hausbrandt, imprenditore e uomo di cultura, grazie al quale entrano a far parte delle collezioni del Museo Revoltella gli autoritratti dei più importanti protagonisti triestini dell’arte tra le due guerre.
In marzo si apre la mostra “Arte e Nazione. Dagli Induno a Fattori nelle collezioni del Museo Revoltella” per ricordare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Il percorso si snoda attraverso le sale del palazzo baronale.
Durante l’estate la mostra “Vittorio Bolaffio e il porto di Trieste” ricorda lo straordinario artista goriziano a ottant’anni dalla sua morte. La rassegna presenta anche una ricca documentazione bibliografica a testimonianza del mondo letterario e artistico al quale Bolaffio apparteneva.
Le opere di Bolaffio offrono lo spunto per organizzare il laboratorio estivo dedicato ai bambini “Il mio primo fumetto! Disegno, collage, grafica”, a cura di Carlotta Buiatti, grafica, designer e illustratrice, attiva per molti anni a Parigi alla Walt Disney Company.
In settembre si inaugura la mostra “Corrispondenze d’arte – Interventi d’arte contemporanea a colloquio con il Museo Revoltella”. L’esposizione distribuita in tutto il Museo fa scoprire al visitatore una ventina tra opere e progetti speciali (installazioni, giochi di luce e colore, artigianato, fotografia, musica). All’inaugurazione performance di danza verticale, arte e musica contemporanea.
In dicembre viene esposta in mostra la collezione di Leopolodo Kostoris con un percorso di 220 dipinti di piccolo formato degli artisti più significativi del Novecento italiano (Carrà, Vedova, De Pisis, Cantatore, Sironi, Rosai, Sassu, Santomaso, Campigli, Afro, Prampolini, Mascherini, Spacal, Crali, ecc.)
Il 28 luglio nell’auditorium del Museo Revoltella viene organizzato il concerto per i 90 anni del maestro Renato Zanettovich, grande violinista e fondatore del Trio di Trieste, che in quell’occasione vede riuniti i suoi migliori allievi.
2012
In febbraio con la mostra e il catalogo “Inediti triestini. Giuliano Brizzi” viene riscoperta una delle figure dimenticate del Novecento triestino, grazie alla collaborazione dei nipoti, che fanno riemergere opere e documenti importanti.
La mostra “Hokusai, Gakutei, Shinsai…Le stampe giapponesi di Frank Lloyd Wright”, inaugurata tra marzo e aprile, viene preceduta da una conferenza sul grande architetto. L’esposizione, allestita al VI piano della galleria d’arte moderna, presenta i 75 esemplari della collezione di Surinomo della Frank Lloyd Wright Foundation in Arizona.
Viene organizzata la mostra “Trieste-Suez. Storia e modernità nel ‘Voyage en Egypte’ di Pasquale Revoltella” per ricordare il 150° anniversario del viaggio compiuto nel 1861-62 da Pasquale Revoltella al Canale di Suez in costruzione. Il percorso si snoda attraverso la Sala Scarpa e i tre piani della dimora baronale.
La mostra “L’arte, l’architettura, il design nella Trieste degli anni ’20 e ’30” unisce nello stesso percorso arte, architettura, arredamento e fotografia, attingendo alle collezioni del Museo Revoltella, dei Musei di Storia e Arte e all’Archivio Tecnico Comunale.
Tra il 2012 e il 2013 al VI piano della galleria d’arte moderna vengono ospitati gli artisti Graziano Negri, Massimo Poldelmengo e Mario Palli in una mostra dal titolo “Contemporanea/mente”, che coinvolge il ParCo di Pordenone, Il Revoltella e la Galleria Spazzapan di Gradisca.
Nella Sala Scarpa viene allestita la mostra “Rerouver Trieste”, collegata al progetto “Piazza dell’architettura”, cui partecipano cinque fotografi per indagare sulle risorse del territorio al fine del loro riutilizzo.
2013
In marzo si apre la rassegna “In primavera a Trieste”, che prevede un itinerario all’interno del museo per scoprire i fiori dipinti e al VI piano della galleria una mostra d’arte contemporanea intitolata “Primavere ribelli”. Fino a giugno si organizzano conferenze su tematiche legate all’evento.
A due anni dalla scomparsa di Sergio Molesi, intellettuale appassionato e straordinario docente di storia dell’arte, la famiglia dona il meglio della sua biblioteca al Museo Revoltella, con il quale Molesi aveva collaborato come membro del curatorio e firmando il catalogo del 1970 assieme a Franco Firmiani. Il 25 luglio Molesi viene ricordato con un incontro a cui partecipano amici ed ex allievi e con l’intitolazione a suo nome della biblioteca del museo.
Durante l’estate si organizza la mostra “Kounellis Trieste”, un progetto espositivo di grande impatto visivo ed emotivo con il quale viene riempito l’ampio spazio del Salone degli Incanti.
In ottobre si inaugura la retrospettiva “Theatrum mundi” dedicata all’artista dalmata Jagoda Buić. La mostra, che viene realizzata con il Museo di arti applicate di Zagabria, è allestita su progetto dell’artista nel V e VI piano della galleria. Il mese seguente con il direttore del museo di Zagabria si organizza una conferenza sull’istituzione croata fondata nel 1880.
Il 14 dicembre si presenta al pubblico un dialogo tra esponenti delle due culture, italiana e croata: ospite d’onore il critico d’arte Gillo Dorfles.
2014
In febbraio si organizza un incontro a più voci su Ugo Guarino per anticipare i contenuti della rassegna dedicata all’artista. Sono presenti personalità della cultura, della sanità e della politica triestina che hanno avuto con Guarino rapporti di amicizia e di collaborazione professionale.
All’inizio dell’anno con l’esposizione dal titolo “Memorabilia” viene presentata l’opera di Franko Vecchiet, artista, intellettuale, docente e critico, appartenente alla comunità slovena di Trieste.
Al poeta e critico Emilio Dolfi, protagonista del futurismo giuliano, si dedica una mostra in cui viene esposto il suo archivio, concesso dalla figlia Giuliana, autrice della biografia che accompagna l’iniziativa.
In novembre si inaugura la mostra “Enzo Cogno. Antinomie”, promossa da Carlo de Incontrera e da altri protagonisti del secondo Novecento triestino. Enzo Cogno, tra gli anni Sessanta e Settanta fu protagonista, assieme a Miela Reina, di una breve ma straordinaria stagione creativa.
Vista la necessità di effettuare un intervento tecnico nel deposito delle opere d’arte, alcune centinaia di dipinti vengono esposti creando un nuovo percorso dal titolo “Salon Revoltella”. Vengono così aggiunte circa quattrocento opere, nella maggior parte di pittori triestini, alle trecento che solitamente si vedevano nella galleria d’arte moderna.
Il progetto intitolato “Museo illuminato. Arte contemporanea e nuovi percorsi museali” prosegue l’esperienza di “Corrispondenze d’arte” realizzata nel 2011. Questa volta gli artisti sono invitati a mettersi in relazione esclusivamente con le opere delle sale del palazzo baronale; la mostra si avvale di un’elaborata progettazione di effetti audio e video.
2015
Nel centenario dello scoppio della prima guerra mondiale il Comune di Trieste allestisce nel Salone degli Incanti una grande mostra dal titolo “La grande Trieste. Ritratto di una città”. Si crea così un percorso storico dal 1891 al 1914 stabilendo per la prima volta relazioni fra oggetti e documenti di istituzioni diverse (Museo Revoltella e Civici Musei di Storia ed Arte, Fototeca dei Musei Civici, Biblioteche Civiche, Civici Musei Scientifici).
Il 25 giugno al Museo Revoltella si inaugura la mostra intitolata “L’alfabeto essenziale di Ugo Guarino”, che riassume per la prima volta la lunga e articolata carriera artistica di Guarino: grafico, vignettista del “Corriere della Sera”, pittore e scultore, nonché intellettuale impegnato nella riforma psichiatrica a fianco di Franco Basaglia.
Idealmente collegata alla mostra su Guarino, si organizza la rassegna dedicata alla stampa satirica dell’Ottocento dal titolo “Trieste semiseria”, dove viene esposta una selezione effettuata su un immenso materiale conservato nelle biblioteche e nei musei triestini, a partire da quello conservato al Museo Revoltella.
2016
Al VI piano della galleria d’arte moderna viene allestita la mostra “Controcanti. Astrazioni a dialogo”, in cui alcuni capolavori di pittura e scultura astratta del Museo Revoltella (Fontana, Burri, Vedova, Santomaso, Capogrossi, Viani, Pomodoro…) dialogono con opere provenienti da raccolte private (Afro, Manzoni, Tápies, Arp, Hartung, Kiefer…).
In aprile si inaugura la mostra “Le due lagune” per ricordare Giuseppe Zigaina a un anno dalla sua scomparsa. L’esposizione mette a confronto i disegni inediti di Pasolini e le incisioni di Zigaina, due diverse interpretazioni dell’ambiente lagunare di Grado.
Vengono presentate al pubblico otto sculture di Carlo Sbisà, donate dalle figlie dell’artista. Si tratta di ritratti di amici di famiglia, realizzati in materiali diversi, che testimoniano la svolta artistica di Sbisà, dopo che nel secondo dopoguerra inziò a lavorare la terracotta e la ceramica.
Si ripropone la manifestazione “Revoltella Estate” con visite guidate, proposte musicali, iniziative enogastronomiche, intrattenimenti letterario-culturali e ritorna lo spettacolo itinerante “Un caffè con il barone”.
Si inaugura la terza edizione di “Corrispondenze d’arte”, che mette a confronto, come di consuetudine, opere di arte contemporanea con opere del Museo Revoltella. Vengono organizzati anche degli incontri con gli artisti, dove il pubblico ha l’opportunità di conversare sulle tematiche e sulle opere della mostra.
Il 28 luglio sulla terrazza del Museo Revoltella viene presentata al pubblico la nuova guida multimediale per visitare il museo in autonomia. Scaricando l’applicazione digitale i visitatori possono approfondire gli aspetti storico-artistici della dimora baronale e oltre 100 pezzi tra dipinti e sculture, sia in italiano che in inglese.
In dicembre si inaugura la prima importante rassegna dell’opera grafica di Giuseppe Lorenzo Gatteri, enfant prodige dell’Ottocento triestino.
2017
Si organizza presso l’Auditorium del Museo Revoltella un ciclo di incontri, a cadenza settimanale, con i responsabili delle tante sezioni e collezioni dei musei triestini. Si spazia dalla pittura dell’Ottocento alla musica, dall’archeologia all’arte contemporanea, dal disegno alla fotografia.
Nei mesi di maggio e giugno l’offerta didattica del Museo Revoltella si arricchisce grazie al laboratorio d’arte dal titolo “Lo spazio sognato. Esplorazione dello spazio urbano”, ideato e condotto dall’artista Elisa Vladilo e rivolto ai ragazzi di età compresa tra 10 e 14 anni.
In giugno si inaugura la mostra “La donazione Malabotta al museo Revoltella”, dove vengono esposte ventuno opere appartenenti alla prestigiosa collezione d’arte moderna di Manlio Malabotta, che vengono donate al Museo Revoltella da Franca Fenga Malabotta.
Durante l’estate viene realizzata una serie di percorsi teatrali, in cui gli attori Sara Alzetta e Maurizio Zacchigna interpretano gli artisti Leonor Fini e Arturo Nathan. Gli spettacoli scritti da Corrado Premuda e Sabrina Morena sono una sorta di dialogo con le opere esposte al V piano della galleria d’arte moderna.
2018
Nell’auditorium “Marco Sofianopulo” per ricordare il 108° compleanno di Gillo Dorfles, a poco più di un mese dalla sua scomparsa, viene organizzato un incontro a più voci intitolato “Essere Gillo Dorfles”.
Durante l’estate si ripropongono i percorsi teatrali “Storie nell’arte” dedicati ad Arturo Nathan e Leonor Fini, ai quali si aggiungono gli spettacoli inediti dedicati a Zoran Mušič di Marko Sosič con Marco Puntin e a Vito Timmel di Stefano Dongetti con Adriano Giraldi.
Nei mesi estivi apre nuovamente al pubblico la terrazza panoramica per due serate alla settimana, nel corso delle quali i visitatori possono fruire di visite guidate al quinto e sesto piano della galleria d’arte moderna.
Il 26 luglio presso l’auditorium del Museo viene dedicato un incontro di approfondimento al docente e critico d’arte Sergio Molesi, a cinque anni dall’intitolazione della Biblioteca a suo nome.
In novembre si inaugura la mostra “Altrestorie – Otherstories”, che offre negli spazi della Sala Scarpa un percorso attraverso ciò che l’arte contemporanea ha saputo dire negli ultimi trent’anni sulla migrazione e l’esilio. La mostra prevede un ricco programma di eventi collaterali.
Viene celebrata la figura e l’opera di Leopoldo Metlicovitz nel 150° anniversario della nascita con la mostra “Metlicovitz. L’arte del desiderio”, dove vengono esposti oltre settanta manifesti di grande formato, alcuni dipinti e decine di esemplari di grafica “minore”.
2019
In occasione della mostra dedicata a Leopolodo Metlicovitz si organizza ogni mercoledì pomeriggio una serie di visite guidate per il pubblico adulto e laboratori di danza educativa per i bambini, che si avvicinano in quest’occasione all’arte in modo del tutto inedito.
Nei mesi estivi, oltre agli eventi culturali proposti sulla terrazza del Museo e alle visite guidate al Palazzo Revoltella, il pubblico ha l’opportunità di rivedere gli spettacoli dedicati agli artisti Vito Timmel e Zoran Mušič, nella rassegna dei percorsi teatrali “Storie nell’arte”, giunta al suo terzo ciclo.
In occasione del 150° anniversario della morte di Pasquale Revoltella (8 settembre 1869), lo staff del Museo continua a proporre una serie di visite guidate a tema per valorizzare alcuni aspetti della vita e dell’attività del suo prestigioso fondatore.
In ottobre si inaugura la mostra “Martin Parr. Life’s beach”, alla presenza dell’autore stesso, che incontra il pubblico presso l’Auditorium del Museo. Nella rassegna il fotografo documentarista britannico propone un viaggio esplorativo nei paesaggi sociali dagli anni Ottanta fino alla metà degli anni Novanta.
2020
L’anno si apre con la mostra “Trieste Settanta. Arte e Sperimentazione”, allestita nella Sala Scarpa, con opere di artisti, testimonianze di operatori culturali e un ricco materiale documentativo sulla produzione artistica della Trieste degli anni Settanta. Vengono organizzati anche eventi collaterali, che vedono la presenza di artisti, galleristi, curatrici e operatori culturali.
In attesa della riapertura dei musei, chiusi per l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid 19, il Museo Revoltella condivide contenuti digitali delle mostre temporanee in corso, propone novità, approfondimenti sulle opere d’arte e laboratori dedicati ai piccoli visitatori da poter fare “a distanza”.
Viene presentata online la pubblicazione del catalogo del ricco materiale grafico di Giuseppe Lorenzo Gatteri conservato al Museo Revoltella, in attesa di poter riaprire il museo e di rendere disponibile il volume presso il bookshop.
L’8 giugno il Museo viene riaperto, nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento del contagio da Covid 19.
Sono visibili al pubblico le quattro opere di maggior valore e bellezza della collezione Malabotta, donata nel 2017, ma che sono pervenute definitivamente al Museo Revoltella durante quest’estate in seguito alla scomparsa di Franca Fenga Malabotta. Si tratta di dipinti degli artisti Arturo Nathan, Vittorio Bolaffio, Giorgio Carmelich e Adolfo Levier.
2021
Nella Sala Scarpa vengono esposte le opere donate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio Zone di Confine, acquisite tra il 1949 e il 1950, ma entrate a far parte delle collezioni del Museo Revoltella solamente nel 1955. Tra gli artisti Giorgio Morandi, Filippo De Pisis, Arturo Tosi e Pio Semeghini.
Il 29 ottobre la Biblioteca d’arte “Sergio Molesi” del Museo Revoltella partecipa all’iniziativa regionale “Un libro lungo un giorno” con delle letture dedicate ai bambini tra i 6 e i 10 anni, nei suggestivi spazi del Museo tra le opere d’arte.
2022
Il Museo Revoltella compie 150 anni e in questa occasione avvia i mercoledì con il conservatore (visite guidate a tema) e una serie di laboratori creativi di danza educativa dedicati ai bambini.
In occasione della XII edizione della campagna nazionale “Il Maggio dei libri” intitolata “ContemporaneaMente. Leggere per comprendere” viene offerta ai visitatori una visita guidata alla Biblioteca storica del Museo Revoltella e alla Biblioteca d’arte “Sergio Molesi” dal titolo “Leggere il passato e ritrovarlo nel presente”.
Ogni ultimo mercoledì dei mesi di giugno, luglio e agosto continuano le letture d’arte per bambini, in versione “estiva” sulla terrazza del Museo Revoltella, che, visto il successo, proseguiranno anche nella stagione seguente.
Per i cinquant’anni dalla morte di Giuseppe Capogrossi la Fondazione a lui intitolata ha ideato un progetto dal titolo “Capogrossi. Il segno nei Musei e nelle Istituzioni italiane”, che coinvolge per tutto il mese di ottobre circa venticinque istituzioni. Il Museo Revoltella vi partecipa con il laboratorio creativo di danza educativa riservato ai bambini (6-10 anni).
Il 3 novembre si inaugura la mostra “La scultura nelle raccolte del Museo Revoltella. Da Canova al XXI secolo”, nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni dalla fondazione del Museo. Il ricco percorso espositivo valorizza la straordinaria collezione scultorea custodita nelle collezioni del Revoltella.
2023
A corredo della mostra “La scultura nelle raccolte del Museo Revoltella. Da Canova al XXI secolo” viene offerto al pubblico un ciclo di incontri e visite guidate. Ad inaugurare la rassegna è lo storico dell’arte Nico Stringa con la presentazione del volume “La Scultura. Museo Revoltella Galleria d’arte moderna”, il ricco catalogo scientifico della collezione, che raccoglie duecento schede di approfondimento.
In occasione della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” si tiene presso la Biblioteca d’arte “Sergio Molesi” e la “Biblioteca baronale” una visita guidata aperta a tutto il pubblico. Nello stesso mese viene offerta una visita guidata ai docenti della scuola primaria che hanno aderito al progetto “La biblioteca d’arte va a scuola”, che prevede il prestito di libri d’arte alle scuole primarie di Trieste.

